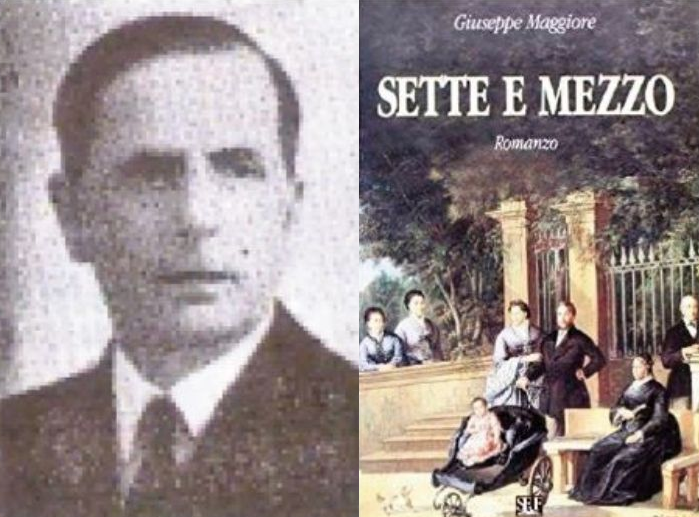di PIER FRANCESCO ZARCONE
(segue dalla I PARTE)
La realtà corale espressa dal romanzo di Maggiore è di segno storico (e non solo letterario) e offre un quadro del tutto diverso che trova corrispondenza – senza andare tanto lontano da noi – nei combattenti dell’Evis per l’indipendenza siciliana dal 1944 al 1946 e nei martiri per essa come Antonio Canepa; nei sindacalisti come Placido Rizzotto, in Falcone, Borsellino, e tanti altri in cui si è incarnata una sicilianità non gattopardesca. Sette e mezzo è un vero e proprio romanzo storico mentre Il Gattopardo si incentra sulle vicende del principe-zio e di Tancredi e sulle loro psicologie.
All’uscita del Gattopardo la sinistra italiana era egemonizzata da un Partito Comunista ancora permeato da stalinismo culturale e portatore di una specifica vulgata del marxismo, per cui non stupisce che l’accoglienza iniziale sia stata di ostile indifferenza, attribuendo al romanzo un pregiudizio ideologico e immobilistico e vendendolo come l’esaltazione di un latifondista reazionario. In seguito, però la stessa opera ebbe recezione favorevole e non è difficile capirne il perché.
Condizionato dalla politica estera dell’Unione Sovietica e da un’assolutizzazione del concetto di lotta di classe, il Pci aveva sempre preso le distanze in modo ostile rispetto alle pulsioni indipendentiste siciliane(3), anche nella loro componente di difesa di identitarie aspirazioni etnico-culturali e di solidali interessi territoriali. D’altro canto è pur vero che a tutt’oggi in Europa non c’è spazio per le identità etnico-culturali che vogliano fuoriuscire dagli spazi accordati loro dai cosiddetti «Stati nazionali» che la compongono: a meno che, ovviamente, non esistano interessi di tipo imperialista con l’intenzione di sfruttarle. A ben vedere la sicilianità del Gattopardo non fuoriusciva dagli schemi vigenti ed utili, e per certi aspetti era anche coniugabile con la sicilianità deteriore di una satira estremamente diffusa e diventata luogo comune sovrapposto alla possibilità di cogliere più sfaccettati aspetti della realtà isolana. La Sicilia del Gattopardo – a differenza di quella di Maggiore – aveva in definitiva tutti i caratteri per assurgere a destinataria della propaganda politica del Pci, e il suo vuoto ideologico andava valorizzato per la neutralizzazione nei Siciliani degli aneliti di riscatto nazionale.
E alla fin fine era anche possibile individuarvi germi di lotta di classe, magari non in senso propriamente marxista, ma come scontro fra «gattopardi» da un lato e «iene e sciacalletti» – borghesi e piccolo-borghesi – dall’altro. E non vi è dubbio che, mercé il suo successo, Il Gattopardo abbia contribuito assai a configurare un certo modo di percepire la Sicilia e i Siciliani. Già Elio Vittorini aveva inutilmente fatto presente a Togliatti come mediante quel modo di procedere la posizione culturale del Pci si risolvesse in oscurantismo, in quanto portava nel campo della cultura – col travestimento di giudizi culturali – ostilità politiche e considerazioni d’uso politico. (3) Anche se dopo il fallimento dell’indipendentismo taluni suoi esponenti dell’ala di estrema sinistra, come Antonino Varvaro, aderirono – non essendoci altro – al Pci.
Nell’opposta configurazione di Sette e mezzo troviamo senza dubbio una sicilianità perdente, a differenza dei noti successi di quella gattopardesca, ma il problema non sta qui: in Maggiore c’è la consapevolezza dell’inevitabilità dell’assunzione delle sconfitte nel corso delle vicende storiche individuali e collettive, tuttavia unita all’esigenza di rialzarsi e al potersi rialzare di continuo per riprendere «l’impresa». In questo romanzo esiste quindi una filosofia dell’azione quale asse di svolgimento della vita, sempre che si voglia (come si dovrebbe) conferire alla vita la dignità per essere vissuta.
Si tratta di una sicilianità che vive di progetti, di speranze e mete da conseguire ed è animata da ben chiari valori strutturanti: dignità personale e collettiva, anelito alla giustizia, fedeltà alla parola data e coerenza nella sua concretizzazione, determinazione a non piegarsi quand’anche sussista il rischio di essere spezzati. Un cinico potrebbe parlare anche di gusto per le «cause perse». Escluderlo potrebbe essere azzardato. Comunque, per capire questo fenomeno non è necessario ricorrere alle complicazioni della psicologia siciliana, ma è sufficiente riflettere su cosa ciò significhi. Battersi per una causa persa significa seguire fino in fondo l’etica del dovere, anche a prescindere dall’aver insegnato la Storia che a volte le cause apparentemente perse non sono poi tali. È qualcosa di assimilabile all’amore senza speranze concrete, ed è quindi un sentimento «puro», valevole per sé stesso e da cui non ci si aspetta nulla in cambio. A ben guardare, è difficile che un essere umano possa dedicarsi a qualcosa di più elevato.
E c’è di più. A fronte dell’aristocratico disprezzo ostentato da Tomasi di Lampedusa verso l’ebreuccio tedesco di nome Karl Marx, (4) nel romanzo di Maggiore troviamo uno dei fratelli dell’altrettanto nobile protagonista – cioè Federico – che, dal non positivo contatto umano con Marx e con Pisacane nonché da quello teorico con Bakunin, sviluppa una propria utopia sociale di taglio socialista cristiano: «Tendere la mano misericordiosa ai poveri, ai derelitti, ma senza concitarli alla rivolta e aizzarli alle sanguinose espoliazioni. Attuare il regno di Dio in terra, spontaneamente, senza attendere che gli esclusi lo rapiscano con violenza». (5)
Qui non importa l’innegabile grado di illusorietà di tale concezione: importa invece che appartenga alla sicilianità di Maggiore e manchi in quella di Tomasi di Lampedusa.
In tutto questo sta il carattere di Sette e mezzo come opera antigattopardo. D’altro canto è sintomatico il raffronto tra come venne sostanziato il concetto di «verità» da questi due scrittori. Per Maggiore «la verità è un atto di coraggio. Dal vile non ci si può aspettare che la menzogna. Infamie!». (6) Tomasi di Lampedusa, invece, definiva sovente la verità quale «la più banale delle interpretazioni possibili di un fatto».
La perdurante prevalenza di «gattopardi e tancredi» di vario genere non è né fatale né fisiologica, bensì determinata da una diffusa e perdurante mancanza dovuta a specifici fattori storici: la loro risultante è stata ed è l’essere venuto meno della possibilità di autoidentificarsi come popolo e Stato, ovvero come Nazione, quando invece Nazione la Sicilia lo era stata per secoli, prima di essere ridotta, dopo il 1860, a regione periferica di uno Stato centralizzato e in definitiva straniero. Infatti, tutte le volte che è sembrato superabile lo stallo di cui parliamo, allora la risposta di massa c’è stata eccome, a prescindere dalle valutazioni qualitative e politiche che se ne facciano. E allora abbiamo avuto ben 90 anni di guerra per l’indipendenza contro gli Angioini e, per un certo periodo, tanto contro di essi quanto contro il regno d’Aragona; la rivolta siciliana del 1848; l’entusiastica partecipazione al 1860, naufragata nella più cocente e totale disillusione; (7) la rivolta antiunitaria dei «sette giorni e mezzo» nel 1866; la lotta politica e armata del Movimento per l’Indipendenza della Sicilia (Mis) e dell’Esercito Volontario per l’indipendenza della Sicilia (Evis) ancor prima dell’avvento della repubblica italiana.
Poi il riflusso, e da molto tempo c’è una mefitica palude. Tuttavia la storia non finisce oggi.
(FINE)
Riferimenti:
1. Come per esempio in Daniele La Barbera, Freud e il Gattopardo, Euromediterraneo 2001.
2. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Feltrinelli, Milano 1958, pp. 232-3 3. Anche se dopo il fallimento dell’indipendentismo taluni suoi esponenti dell’ala di estrema sinistra, come Antonino Varvaro, aderirono – non essendoci altro – al Pci.
4. Giuseppe Maggiore, Sette e mezzo, Flaccovio, Palermo 1963, p. 241.
5. ibid., p. 194
6. ibid., p. 74.
7. L’insurrezione dell’aprile 1860 riguardò direttamente la famiglia di chi scrive, e ancora la si ricorda in quanto un suo membro, Francesco Migliore, fu ucciso nei combattimenti al monastero palermitano della Gancia